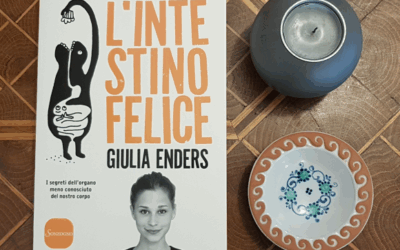Ho tenuto Farmageddon nascosto in libreria per qualche anno. L’ho comprato con grande interesse dopo aver visto una breve intervista al suo autore, Philip Lymbery, ma non avevo il coraggio di aprirlo: temevo una scossa così grande alla mia sensibilità da non riuscire poi ad avvicinarmi alla tavola senza il magone. Poi, complice una serata divulgativa sulle proprietà della carne in previsione con l’associazione 9 Nuvole (purtroppo saltata per emergenza Covid), mi sono decisa.
Effettivamente è stata una grande scossa e in modi che neanche immaginavo, ma una scossa costruttiva. Mi spiego meglio.
Il punto di partenza
L’autore è direttore generale del Compassion in World Farming, la maggiore organizzazione non governativa per la protezione e il benessere degli animali da allevamento. Nel libro, scritto insieme alla giornalista Isabel Oakeshott, racconta il suo viaggio attorno al globo alla ricerca di informazioni sugli allevamenti intensivi di animali terrestri e di pesce.
Con una premessa di questo tipo, mi aspettavo un libro denso di racconti sulla sofferenza animale e in effetti gli esempi non mancano: galline così pressate in gabbie da arrivare a cannibalizzarsi, mucche da latte spremute fino a livelli inimmaginabili, pesci che nuotano in tondo in vasche troppo piccole. E’ tutto molto ben documentato, senza scadere nel macabro e nell’inutilmente cruento.
Ma nel libro ho trovato molto di più.
L’impatto ecologico
Sganciare l’allevamento dall’agricoltura, smontare la fattoria tradizionale fatta di comunione tra colture diverse e animali di varie specie ha portato una devastazione in termini ecologici di proporzioni enormi.
Da quando la maestra Silvana alle elementari ci fece notare quanta acqua sprechiamo se non ci facciamo attenzione, la chiudo sempre diligentemente mentre mi spazzolo i denti. Giustissimo, ogni piccolo gesto è importante, ma nulla in confronto alla scelta di quale bistecca buttare in padella per cena.
L’allevamento intensivo richiede innanzitutto grandi quantitativi di mangime, che non vengono prodotti in zona, ma in estese monocolture, magari dall’altra parte del mondo. Le monocolture richiedono grande uso di fertilizzanti chimici e grandi spostamenti per portare alla mucca un mix di mais e soia, che le farà pure male, perché è nata per mangiare erba. E’ come se la specie umana fosse in grado di mangiare solo insalata e venisse costretta a cibarsi di polenta e tofu: forse forse un po’ di mal di pancia ci verrebbe, no? E come sarebbe la qualità del nostro latte?
Api in affitto
Forse uno dei passaggi più inaspettati del libro è quello riguardante la necessità di allevare e affittare api.
Quando coltivo un solo tipo di pianta e utilizzo pesantemente diserbanti e insetticidi, otterrò piantagioni surreali: in California si possono vedere ettari ed ettari di mandorli senza avvertire un solo brusio d’insetto o vedere il passaggio di un uccello. Questo non è solo inquietante in termini paesaggistici, ma è un problema pratico: chi si occupa dell’impollinazione? No api no party.
Per garantire il raccolto, gli agricoltori sono quindi costretti ad affittare sciami di api che vengono trasportati su strada in enormi camion. Sul serio.
Anche se certamente non è il capitolo più toccante del libro, secondo me è uno dei passaggi che rende meglio fino a quale punto ci siamo spinti per ottenere di più dal nostro malconcio pianeta.
Dal letame nascono i fior
Così cantava De Andrè. Purtroppo in modo impreciso: dal letame nascono fiori e piante se allevamento e agricoltura convivono e si aiutano a vicenda. Coltivo qualcosa, l’animale lo mangia e in cambio mi dà il concime per il raccolto successivo.
Ma cosa accade se coltivo soia in Sud America e allevo maiali in Cina? O raccolgo mais negli Stati Uniti e produco latte in Europa?
Accade che gli allevamenti intensivi producono quantitativi di deiezioni al pari di grandi città e da qualche parte tutto questo liquame dovrà essere smaltito. Vicino agli allevamenti si creano enormi laghi di letame che nella maggior parte dei casi non hanno buona tenuta e inquinano l’acqua di falda, i fiumi e il mare.
La sofferenza umana
Acque inquinate e aria insalubre hanno un forte impatto sulla vita delle persone: in alcune zone del mondo abitare vicino ad un allevamento significa avere una speranza di vita ridotta di 10 anni e un rischio aumentato per moltissime patologie.
L’obiezione più comune è che però in questo modo è possibile aumentare la produzione di cibo per ridurre la fame nel mondo.
Per dirla con le parole dell’autore “La gente ha fame perché è povera”, non per la mancanza di offerta (anche perché in realtà sprechiamo così tanto cibo da poterci sfamare tutti). Sono rimasta particolarmente toccata dalla storia dei bambini peruviani vittima di malnutrizione: tutto ciò che viene prodotto nella zona (in questo caso pesce), viene venduto come mangime animale. Ciò che potrebbe salvarli viene dato via per denaro.
Non avevo idea di quanto le nostre scelte alimentari potessero contribuire così tanto alla sofferenza altrui.
La soluzione
Dopo 300 pagine di rivelazioni e sconforto, arriva salvifica l’ultima sezione: cosa possiamo fare?
Non necessariamente diventare vegetariani o vegani. Certo, difficile non esserlo se non possiamo accettare la morte animale. Se però pensiamo che il cibarsi di prodotti animali sia in qualche modo per noi naturale (non sto esprimendo opinioni personali, le questioni etiche richiedono molta più attenzione di qualche riga nella recensione di un libro), dobbiamo per forza trovare il modo di ridurre la sofferenza animale e umana.
Lymbery ci spiega come con un’alimentazione locale, stagionale, un’attenta lettura delle etichette sia possibile fare molto. E qui ho tirato un sospiro di sollievo, perché per fortuna faccio e divulgo tutto ciò da anni. Torniamo dai produttori locali, chiediamo al macellaio come vivono gli animali che ci sta vendendo (e mannaggia, questo era proprio il tema della serata a 9 Nuvole!), parliamo con i contadini. Un po’ per volta, senza ossessioni ma con costanza.
Possiamo sempre girare la testa dall’altra parte, far finta di non sapere: ma siamo veramente sicuri di volerci caricare il peso di tanto dolore umano?
“Questo non è un elogio al vegetarianesimo. Non è un libro contro la carne. Ma è un grido d’allarme che non possiamo ignorare”
The Independent